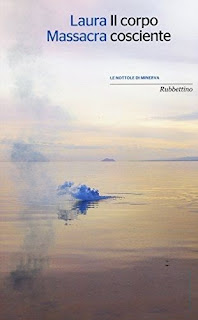Written by Francesca Coin, 07.02.2011
ovvero di rivoluzione e miele
ovvero lettera ai compagni (e a Jung)
1.
Vorrei parlare di una storia d'amore, quella tra Carl Gustav Jung e
Sabina Spielrein. Il mio scopo in realtà è provare a discutere con un pò
di cognizione di causa il cosiddetto scandalo sessuale che attuttoggi
nella sua miseria eccita i media. Premetto che poco m'importa della cosa
in sè, m'importa il fatto che tale scandalo abbia in realtà ben poco di
scandaloso, anzi costituisca la prassi stessa in cui muovono oggi
destra e sinistra istituzionale e non, ovvero buona parte dei potenti
insieme ai rivoluzionari.
Scrivo questo per ragionare in ultima analisi non tanto sulla
differenza, quanto piuttosto sul desiderio, dopo che per decenni il
mercato ha tentato di eccitarlo, di sublimarlo, di trarne valore, di
atrofizzarlo, di capitalizzarlo, di trasformarlo in plus-godere direbbe
Zizek. L'oppressione del desiderio collettivo si riflette in molte cose,
ma anzitutto nelle relazioni tra maschile e femminile, inteso sia come
controsessuale che come intersessuale, rilegando spesso la differenza ad
intermezzo, passaggio dal positivo al negativo del negativo che è il
positivo ancora, in un processo in cui la donna figura ancora come
stampella anfetaminica di scalata all'onnipotenza. La strumentalità del
femminile come intermezzo di carne e sorgente di amor di sé, come
meravigliosa stampella carnale e psichica di un ordine primitivamente
patriarcale, vale oggi in Italia per uomini maschilisti e femministi
insieme. Peggio, vale anche per quel femminile che fa di tale stampella
uno strumento per competere nel capital/Edipo. Su questa falla abissale
poggia oggi un processo di rigenerazione divenuto oramai
imprescindibile.
Il processo di distruzione e rinascita che oggi c'impone rapidamente di
ripensare in termini anzitutto redistribuitivi una struttura sociale in
crisi terminale, non può per un istante in più prescindere dal
rimescolamento amoroso ed orgiastico del desiderio maschile e femminile
insieme nelle moltitudini, fuori ed oltre l'ordine fallologocentrico cui
l'hanno rilegato – rilegandovisi - compagni e padroni, sino ad una
profonda rivoluzione delle relazioni affettive. Questo riguarda oggi
tutti: donne e uomini insieme, rivoluzionari e potenti. Poco m'importa
dei potenti, che la strada la faranno soli a partire dall'inferno.
M'importa per amor di loro e di noi stesse di quei compagni con cui è
giunta l'ora di muovere oltre l'impasse che rifiuta di parlare alla
donna orizzontalmente e fuori l'intermezzo, per rinnegare dal basso una
relazione con il femminile che troppo spesso ancora si fa orizzontale
solamente nei letti.
Comincio dunque da una storia d'amore perchè essa è, al contempo,
meravigliosa e straziante. Ancor più è simbolica del potenziale
poeticamente terrorista del desiderio, un potenziale che dirompe dentro
ed oltre il doppio legame che storicamente ha tratto forza dal bisogno
psichico, sociale e politico di proteggere il maschile dall'“altro”, un
bisogno figlio della società competitiva del capital/Edipo e la cui
potenza immanente e libera sola può riportare la vita nostra e di tutti
verso un nuovo dis/ordine sociale non più contraddittorio al desiderio.
Il desiderio primordiale di trascendere sé che è insieme morte e
rinascita, e che nel suo abbandonarsi per muovere oltre sé in un
incontro con l'alterità è un processo meravigliosamente proletario, opta
qui, nell'Occidente contemporaneo e barbarico, in un processo di
protezione dell'esistente di fronte all'abisso del perturbante, una
protezione che per meccanismi psichici e sociali ricorda la rimozione
dell'altro dell'ordine autoritario fascista, e che così facendo nega la
trasformazione economica, politica, affettiva e spirituale della società
tutta. La forza costituente che si è a ragione e a diritto oggi imposta
sul dibattito politico mondiale non può portar con sé i rimasugli
del(lo) (piedi)stallo del maschile, del femminile e delle relazioni
umane tutte, nè prescindere da un processo di distruzione e rinascita,
anzi la sua prima vittima dovrà per forza essere quel bulimico
moltiplicarsi del “more of the same”, quell'uno atrofizzato e mille vote
decrepito che ancor oggi sopravvive come una malattia dalla finanza al
pensiero sino ai letti, anzitutto in Italia.
Comincio dunque da una storia d'amore per comprendere che cosa
significhi qui ed oggi “terrorismo” del desiderio, utilizzando come
metafora introduttiva una relazione a due simbolica di ben di più di
due, in quanto essa siede non solo alle origini della psicanalisi, ma
anche, e per le stesse ragioni, all'origine della diffusione sociale
delle sue manipolazioni, portando a un doppio legame con il femminile
che trova espressione a un tempo nella triade proprietà, famiglia e
stato, e nella doppia morale di una società il cui dissesto trova negli
scandali ultimi solo il sintomo ultimo di tale triade, la punta di un
iceberg costruito sopra un letto di marcio. Tento dunque una riflessione
contorta, lacunosa e disagiata al fine ultimo di reinserire nella lotta
l'amore.
2.
Sabina Spielrein e Carl G. Jung furono una coppia di amanti le cui
vicende sono state raccontate qualche anno fa da Aldo Carotenuto,
psicanalista di Napoli che per primo ha avuto accesso al carteggio di
lettere scambiate, in quell'inizio novecento, dai tre psicanalisti.
Maledetta Felicità, gridava allora Carl Gustav Jung alla sua amante,
Sabina Spielrein, in un momento di abbandono. La donna, bella, giovane
ed intensamente perturbante, era stata dapprima sua paziente e poi la
sua amante, infine una collega, pur rimossa dagli archivi della
psicanalisi come ombra minacciosa nella scienza legittima di Freud e
Jung. Maledetta felicità, gridava lui, dimenticando per un istante la
moglie, la carriera e la società vittoriana di cui egli era magistrale
simbolo. Quell'amore lo faceva acqua e vulnerabilità. Terrore, in altre
parole, era per lui l'amor per lei, il cielo stesso e l'abisso,
l'infinito e la propria infinita minuzia. Da questa intensa storia
nascono lunghe pagine di psicanalisi, un pensiero che non a caso
dispiega dalle relazioni tra gli esseri umani e che da tali relazioni
viene parimenti, come ricorda Luce Irigaray, delegittimato.

Aldo Carotenuto ripercorre questa storia d'amore e le sue implicazioni
nella teoria e nella pratica psicanalitica, implicazioni su cui
ritornerò dopo. Diciamo solo che Jung ebbe in cura Sabina inizialmente
come paziente. Lui era il suo medico e lei una donna straordinariamente
bella, di un'espressività corporea grezza e dirompente. Lei era il
perturbante, quel familiare che porta con sé come un oceano il magma
dell'inconscio. Lui era un medico di grande promessa che adorava lei
come di lei il transfert, l'onnipotenza di sé riflessa negli occhi di
lei per cui lui, medico guaritore, era persona “potentissima che tutto
può”. Declino in romanticismo le gerarchie di genere sottese al loro
rapporto d'amore agli inizi, ma è ovvio che queste sono fondamentali:
lui la conosce fragile e malata, e non è possibile negare che la
passione di Jung per Sabina trovò sicurezza ed espressione proprio in
questa vulnerabilità. Amare è dare ciò che non si è a qualcuno che non
lo vuole, avrebbe detto Lacan, e la prima metà di quest'affermazione
trova qui conferma: lui amava in lei la potenza propria che lei vedeva
ed amplificava, enfatizzandone con la propria vulnerabilità il miraggio
d'infinito, infinito che egli, non a caso, dubitava. Si può pensare
dunque che il loro rapporto si sia sviluppato in una situazione di
asimmetria acquistando tutte le connotazioni di un rapporto
narcisistico, scrive Carotenuto, ed in un certo senso è così. Ma se
togliamo Sabina dalla condanna storica all'intermezzo vediamo invece che
lei, donna di sottile e sofisticata complessità, decifrava in lui ciò
che egli stesso non riconosceva. Un po' come Dioniso amava di Arianna
ciò che mai avrebbe potuto amare un Teseo, scriveva Nietzsche, così lei
percepiva in Jung ciò che solo una sensibilità complessa poteva
riconoscere, e con forza coraggiosa, la stessa forza dionisiaca che
appunto fece poi di lei una rivoluzionaria, non smise di morire e
rinascere le turbolenze di un sentimento che mai ebbe la viltà di
rinnegare. “Diario di una segreta simmetria”, s'intitola non a caso il
testo di Carotenuto, perchè l'amore avido e generosissimo di lei,
coraggioso e commovente si affianca all'amore vile di lui, che nella
viltà cercava segretezza e nel terrore rivelava dilagare.
Fu impossibile per Jung calarsi nel mondo di Sabina senza che questa si
impadronisse di lui, scrive Carotenuto. “La seduzione è come un gas
inodore inalato, i cui effetti si avvertono soltanto quando
l'avvelenamento è già avvenuto” (Carotenuto, 87). Il loro rapporto parla
dunque di una conoscenza psichica profonda, che fu “la nascita di un
dio che è come il profumo di Baudelaire, si può goderne ma non è mai
completamente qui, è insieme corpo e negazione del corpo”. Su
quell'infinità abissale, effimera e pervasiva s'infrangeva Proust,
quando riconosceva nell'amore un essere che si estende a tutti i punti
dello spazio e del tempo che esso ha occupato e occuperà, ma che egli
non toccherà mai. Un amore disarmante e mai raggiungibile, dunque,
infinito ed abissale come l'universo stesso ed in cui Jung naufragava in
tutta l'umana minuzia.
Troppa immensità dunque per un piccolo uomo? Verrebbe da dire di si,
alle volte, volendo essere semplicistici, d'altro canto l'arte
occidentale non dice che questo. “Ciascuno uccide le cose che ama,
diceva Jeanne Moreau in Querelle de Brest di Rainer Werner Fassbinder:
“alcuni uccidono l'amore da giovani, altri quando sono vecchi, chi lo
strangola con la passione e chi con l'oro, i più gentili usano il
coltello perchè il cadavere si raffreddi prima. Ciascuno uccide le cose
che ama, alcuni amano poco altri troppo a lungo, alcuni lo vendono altri
lo comprano, alcuni lo fanno piangendo altri senza neppure un sospiro.
Così ogni uomo uccide le cose che ama, e nessun uomo muore”. Nessun uomo
muore mentre uccide le cose che ama, anzi le uccide per sopravvivere. È
questa la legge triste che ci ricorda Natoli e che cinicamente dovremmo
forse tener presente.
Ma Natoli a parte, che pur con questa matrice ci spiega guerre e
stermini, così ci dicono anche R.D.Laing e Pasolini, Baudleaire e Jorge
Enrique Adoum, Pessoa e Derek Walcott. “Dimenticherò il sentire,
disimparerò il mio dono. E' più grande e arduo questo, di quanto là
passa per vita”, scriveva Walcott. Disimpariamo il sentire, sono molti
gli uomini che hanno parlato con certo compiacimento dei benefici della
rinuncia. E come loro, così faceva Jung. Jung era in difficoltà: “Il mio
animo è lacerato sino nel più profondo […] Saprà perdonarmi di essere
così come sono? [...] Lei saprà capire e accettare che sono una delle
persone più deboli e incostanti?” “Queste esperienze […] hanno scatenato
l'inferno in me”, scriverà lui. E così Jung combattè lei, se stesso e
la loro relazione per tutta la vita, rifuggendola, umiliandola. Ne
scrisse a Freud, che commenterà le “astuzie psichiche inimmaginabili” di
queste donne (Carotenuto, 121), prima di essere a sua volta conquistato
dall'intelligenza sensibile e brillante della Spielrein. Jung ne
scriverà poi alla madre di Sabina, chiedendole un “adeguato onorario”
per le visite alla figlia, perché “non avendo mai preteso un compenso,
non mi sento impegnato come tale” (Carotenuto, 121). Il denaro
rappresenta allora lo strumento vile di continenza cui aggrapparsi per
limitare il proprio tormento, onorario che insieme al concetto di
controtransfert intendeva riportare entro valori vittoriani un desiderio
dirompente. Aveva paura, Jung, e si sentiva minacciato: ho paura del
“destino che mi minaccia”, “paura per il mio lavoro”, per “il mio
obiettivo di vita” (Carotenuto, 120). Jung pregò dunque Spielrein di
aver compassione per lui, di rendergli un po' di quell'aiuto che lui le
aveva dato. Fatto sta che l'amore tra i due diviene lentamente aborto.
Sabina si allontana, ma non porterà mai, come dirà Freud “alla luce
l'odio che gli si addice", né distruggerà l'idolo. Continuerà ad amarlo,
ma i due si perderanno gradualmente. Che cosa terrorizza Jung di
Sabina? È questa la domanda cui Carotenuto cerca di rispondere con
lunghissime pagine. Ma la domanda è più ampia, e ha a che fare con gli
aborti del desiderio, a partire dal maschile singolare, sino alle sue
cause e alle sue implicazioni.
Partiamo dunque da Sabina, in quanto la storia ne ha compreso la
grandezza, ma il ricordo di lei rimane sempre inter-detto dai padri.
Parafrasando Luce Irigaray, potremmo dire che Sabina è inter-mezzo,
stretta dai padri della psicanalisi e di quelli il negativo, l'inverso,
il contrario, forse addirittura il contraddittorio. Le parole della
Irigaray si sposano meravigliosamente con il caso Spielrein, perchè lei è
forse addirittura il simbolo di questo perverso gioco tra scienziati:
carne, cuore e mente di una storia che lei non ha mai scritto, né è
stata autorizzata a scrivere, inter-posta tra due uomini, cerniera nella
loro relazione lacerata dal tentativo di controllare il potere e il
sapere (Irigaray, 17), Sabina era fuori potere, fuori gioco, fuori io e
fuori linguaggio. Sabina si forma nelle parole di Jung, il linguaggio di
lui diventa la vita di lei, da paziente a psicanalista. Lui è
linguaggio e lei è il significato, il contenuto, la teoria, l'amore, ciò
che gli dà vita. Nonostante il suo contributo alla psicanalisi (o
appunto per quello), Sabina sarà dunque il rimosso, il rimosso
dell'affettività di Jung, il rimosso della storia, il rimosso della
psicanalisi. Per tutto questo Sabina “non è”. Torna a mente ancora
Lacan, Sabina non è e la relazione non c'è, e non c'è relazione perchè
non c'è Sabina. Per Jung Sabina è anima e ombra. Jung concettualizzò
dopo l'incontro con Sabina un'idea di Anima di derivazione kantiana
indagabile dalla psicologia empirica. L'immagine dell'anima è per Jung
la donna nell'inconscio dell'uomo, è l'alterità, il femminile, in altre
parole è la modalità eterosessuale interna con cui Jung vuole indicare
l'immagine controsessuale inconscia presente in ogni essere umano. “Ma
non solo il concetto di anima, bensì anche il concetto di ombra - la
personalità repressa, inconscia, autonoma - risale alla Spielrein”
(Carotenuto, 40). Sabina è anima e inferi, e così il femminile scompare
nel metafisico, diviene l'oggetto trascendentale che da Kant a Hegel ha
cancellato l'empiricità della donna facendone un oggetto animico e il
suo contrario. L'anima sposta sul piano del metafisico o del destino una
donna invece immanente, in carne ed ossa, qui ed ora, oltrepassandola,
senza ricongiungervisi mai se non in modo tarslato in un doppio legame
con la bulimia del corpo. Sabina per Jung è traslata, è continuamente
sfocata, non è mai sullo stesso piano.
Così come Emma Goldman avvisava che maggiore è la crescita della donna e
meno possibile sarà per lei essere riconociuta dall'altro non solo come
corpo ma come “quell'individualità forte che non può né deve perdere un
singolo tratto del proprio carattere”, ugualmente Sabina diveniva
gestibile solo traslata, dissezionata o deformata. Ecco che Sabina era
gestibile sino a quando la malattia le conferiva un'identità
vulnerabile, allora la piccola Sabina poteva essere lo specchio
immanente del desiderio di Jung. L'emancipazione di Sabina e del suo
desiderio rende invece la sua immanenza debordante, e Jung ha paura.
“Per molto tempo, ho sempre sentito con diffidenza la parola amore”,
scrive Jung. Il sentimento legato alla donna fu per molto tempo di
naturale sfiducia. Padre significava per me qualcosa di cui ci si può
fidare”. Ma non così fu per madre o donna. Jung equipara l'Anima alla
Madre, simbolo di ciò che avvolge e al tempo stesso soffoca e minaccia.
La caverna, dal mito di Platone origine corporea del feto nell’utero
materno, diviene nel complesso di svezzamento di Lacan un trauma che
obbliga alla “rottura di contiguità con l'interno del corpo della
madre”. Il maschile cercherà sempre di ritornare nella caverna e vivrà
come un trauma “il distacco dalle membrane che avvolgono il feto, il
distacco dal cordone ombelicale, il distacco dall'allattamento”. Ma la
sfiducia, il desiderio continuamente frustrato della caverna come luogo
di riconciliazione tra espansione e protezione non trova consolazione
nel mondo. L'alveo della famiglia, prigione per marito e moglie protegge
ma non espande. L'amante espande ma non protegge. La relazione con la
donna diviene così biforcazione e doppio legame, e si “risolve” nella
storia occidentale da un lato nell'apologia alla famiglia e nella triade
proprietà privata famiglia e stato, e dall'altro nella penetrazione
bulimica di corpi da questa inscindibile. Questo doppio legame psichico
ed emotivo del maschile al femminile, privo di libertà e perfettamente
inserito nel capital/Edipo, non trova entro quest'ordine risoluzione, né
peraltro potrà mai trovarlo, anzi riproduce ancora una volta e
trasversalmente l'esisistente con le sue prigioni.
Il rapporto di Jung con Sabina si risolve dunque in un doppio legame
che biforca il sentimento e lo trasla: Sabina si troverà così spesso a
incarnare la madre, la sorella, la donna amata, la dea celeste e la
strega infernale, l'amata e la minaccia, la fata e la strega. Lei
diventa i fantasmi di lui, ed in questa traslazione vive non solo
l'incapacità di lui di rispondere a tutti i piani di lei, ma un rischio
di disintegrazione per Sabina. Il doppio legame di Jung è per Sabina
tenaglia: la disintegrazione colpevolizzante che lui opera di lei
rischia di frammentarla. L'amor di lei per lui confronta Sabina e si fa
disgregante mettendo a rischio Sabina per intero, la sua immanenza nuda
impreparata a difendersi dal guaritore. Sabina è in una morsa. Scapperà,
diverrà psicanalista lei stessa e si sposerà, ma la sua è una
liberazione inconclusa, in parte vestita di catene. Così lei seguirà le
orme di lui e lo ripercorrerà per riappropriarsi di sé. Indomita Sabina,
della sua fine si sa solo che la sua foga di libertà fu uccisa dalla
mano della repressione stalinista.
Indomita Sabina, e Jung? È un problema il desiderio di Sabina,
identificato su Jung quasi a evidenziare la paura di sperdimento che lei
ha a pensare la disconnessione. Lei l'ha incontrato perduta, e non
riesce a dimenticare che l'unica sua casa fu lui. Il problema volendo in
questo caso si fa più ampio e diparte nel linguaggio: come diceva
Spivak, if we are not who they say we are, then who are we and who are
we not? Ma proprio perchè l'identità è ironicamente inscindibile dalle
relazioni, il problema è anche il desiderio di Jung. Jung infatti si
dispera e perde la ragione. "L'amore di Sabina per Jung ha reso conscio
qualcosa che prima egli presentiva solo in modo confuso, cioè come
potenza che determina il destino dell'inconscio, potenza che nel loro
caso, nel riflettersi delle loro anime doveva essere sublimato o avrebbe
portato alla concretizzazione dell'inconscio” (Carotenuto, 141).
Jung analizza il suo desiderio, lo riallinea alla famiglia, lo traspone
metafisicamente, lo trasla e lo biforca in mille tentativi di
depotenziarlo, di salvarsi la pelle. Jung è esposto ad un magma di
inespresso, un fantasmagorico miscuglio d'ombre senza forma, e non sa
che fare. Sabina risveglia in lui un desiderio rivoluzionario e
distruttivo, gravido potenzialmente di creazione. Ma confrontarsi con il
proprio desiderio significa esserne minacciati: minacciare moglie
famiglia morale professione, la sua immagine di sé. Vacilla, Jung, e la
odia. La odia perchè il desiderio di lei mina la stabilità di lui.
Maledetta felicità, grida tant'è, in modo quasi disperatamente tenero. E
poi ignora, trasla, frammenta. Come un neonato ricorre alla madre, ai
simboli e agli archetipi. Ricorre all'autoanalisi per conoscere il suo
inconscio oppure il suo demone interiore, come lui lo chiama. E poi
fugge, fugge il terrorismo del desiderio e neutralizza Sabina. La uccide
interiormente per continuare a vivere.
Jung preferisce non sentire. Torna alla mente quella lunga letteratura
che vede malinconicamente consolare il maschile della propria
inadeguatezza rispetto al desiderio. Sixto Vazquez Zuleta Toqo, poeta
indigeno argentino, supplica ghiaccio nelle vene per gelare il
desiderio, o il suo piedistallo diventerà pozzo. Pessoa chiede non
l'amore ma i suoi dintorni, perchè possedere significa essere posseduti e
“sciuparsi”. È lunga la lista degli uomini che preferirebbero farsi
masso piuttosto che cedere a un languore perforante, perchè almeno
l'assenza di desiderio consente di stare interi e verticali. Meglio
proteggere l'interezza, meglio rinnegare la vulnerabilità. Ecco che
Hegel usa la negazione solo ai fini di ristabilire l'universalità
dell'uno, ed il femminile come contraddizione da togliere ai fini del
ristabilimento della prima immediatezzza, o della semplice universalità,
così da rifugiarsi di nuovo ed immediatamente nell'altro dell'altro,
nel negativo del negativo che è il positivo, nell'identico,
nell'uniersale (Hegel, 948-949).
Emerge qui una contraddizione vile ed alienante in quanto
paradossalmente la psicanalisi fa proprio questo: isola il desiderio
dalla morale come bandolo che libera la vita, ma la scoperta della
libido come fattore vitale dirompente viene ripiegata dagli stessi
scopritori nel familismo dell'esistente, generando così un
cortocircuito. “La psicanalisi opera così un riallineamento del
desiderio entro i recinti del “Capitale/Edipo”, scrivono Deleuze e
Guattari, che la riporta nel passato cupo dell'esistente. Ecco che il
rapporto col desiderio diviene contraddittorio: riportando “il complesso
familiare stesso nel trasnfert o nel rapporto paziente-medico”,
scrivono Deleuze e Guattari, la psicanalisi fa della famiglia un certo
uso intensivo [e la rende] il gradimetro delle forze di alienazione e di
disalienazione (Deleuze e Guattari, 103). Riallineando il desiderio
alla famiglia o a metafisici archetipi, Jung trasforma così l'apertura
in un eterno ritorno, il desiderio in malattia e l'ordine in salvezza.
Ecco preservata l'interezza, e il potenziale trasformativo del desiderio
viene riportato all'esistente. Parafrasando Foucault, e per giungere al
nocciolo della questione, si potrebbe dire che Jung non fa altro che
difendere il rapporto malato - medico, ovvero il proprio ruolo di
guaritore nella relazione con Sabina ed oltre la relazione con Sabina.
Jung uccide Sabina per salvare il proprio piedistallo. Si riproduce qui
quel vecchio uno nel quale il desiderio voleva violentemente irrompere
rivoluzionandolo. Ma la trasformazione richiede una rivoluzione
interiore, e Jung scappa. Si aggrappa al piedistallo, si rifugia in un
antro leggero e capitalizza la propria debolezza. “Il magnetismo di Jung
per tutti i tipi di donne nevrotiche era rimarchevole”, scrive
Carotenuto. “Una parte del segreto di Jung consisteva nella forte
partecpazione emotiva con donne che erano o si sentivano non capite.
Senza dubbio la sua estrema vulnerabilità femminile contribuì al suo
sex-appeal (Carotenuto, 86). Fatto sta che Jung passa il resto della sua
vita tra gli archetipi e le giovani seguaci. Soffoca il potenziale
dirompente del desiderio, muore dell'implosione interiore della sua
potenza. Cerca indifferenza e probabilmente (non) la trova.
Che cosa spaventa Jung? “E' assolutamente spiacevole dover dire cose
così rudimentali: il desiderio non minaccia una società perchè è
desiderio di andare a letto con la madre, ma perchè è rivoluzionario. E
questo non significa che il desiderio sia qualcos'altro rispetto alla
sessualità, ma che la sessualità e l'amore non vivono nella camera da
letto di Edipo, sognano piuttosto il mare aperto e fanno passare strani
flussi che non si lasciano immagazzinare in un ordine stabilito”
(Deleuze e Guattari, 129). È nell'incontro con la vulnerabilità evocata
dal desiderio che siede il terrore di Jung. Il desiderio infatti “non
vuole la rivoluzione, è rivoluzionario da sé e involontariamente,
volendo ciò che vuole” (Deleuze e Guattari, 129). Il desiderio è
rivoluzione in senso stretto, null'altro è il desiderio se non questo.
In questo senso il desiderio non è bisogno, non è sopperibile attraverso
un processo di addizione o di integrazione, il desiderio
necessariamente distrugge. Disintegra, rigenera, rivoluziona. Disintegra
perchè esercita la sua potenza a partire dal raggiungimento costituente
della crisi. È la potenza del desiderio ciò che sconvolge Jung. Lo
spiega la Spielrein: “la libido ha due aspetti”, scriveva Sabina nel
1912: “essa è la forza che tutto abbellisce ma all'occasione tutto
distrugge” (Spielrein, p. 133). Si capisce la resistenza emotiva di Jung
di fronte alla distruzione. La crisi di Jung non nasce dai limiti che
egli pone al desiderio, ma dai limiti che il desiderio pone a lui. È una
minaccia potenzialmente feconda, quella del desiderio, ma solo
potenzialmente. Il desiderio non promette niente. Il desiderio è un
terrorista. È un veleno d'oppio che ci accompagna inconsapevolmente sino
alla crisi, nel tunnel intermittente di vita e morte, di mondo e
finimondo ove il soggetto deve dominar se stesso e poi aprire aldilà del
conosciuto. Dentro la crisi non c'è strada da seguire. Ci sono buio ed
inferi, fantasmi e ricordi che danzano con un ghigno di profumo ed
inganni. Qual è la strada – non c'è. La strada unica è quella dolce
dell'abbandono al rischio della distruzione. È lì che il desiderio si fa
fecondo. Forse. Forse, perchè il desiderio chiede tutto ma non promette
mai. Qui sta la bellezza del desiderio femminile libero, secondo
Sabina: “una donna che si abbandona alla passione […] sperimenta solo
troppo presto l'aspetto distruttivo”. La meraviglia proletaria del
desiderio di lei sta proprio dunque nella disponibilità all'abbandono:
Sabina morirebbe mille volte nel suo desiderio. Jung invece non lo fa.
Si rifugia nel privilegio e cerca pace.
3.
Eccoci dunque arrivati a dove la questione si diparte da Jung e Sabina,
e diventa una questione politica. Il desiderio represso si esprime
infatti nell'esistente, nel famoso capitale/Edipo, nella competizione
del maschile e nella negazione del perturbante. Fa un errore forse la
psicanalisi a riallineare in termini familistici il desiderio nel
capitale/Edipo, ma fa né più né meno di ciò che ha fatto la storia,
salvo sublimi eccezioni. La competizione e la castrazione come
conseguenze della necessità di proteggere l'Io dalla sua crisi vanno ben
aldilà della romanticissima relazione tra Sabina e Carl. Vanno alle
radici del rapporto del maschile con il desiderio, ed ai conflitti che
esso genera. Il rapporto del maschile con il desiderio è infatti
importante per almeno due ragioni. Primo, perchè il desiderio oppresso
si vendica. Secondo, perchè si vendica sulle donne e sulle relazioni
umane tutte.
I compagni di Maschile Plurale ragionano esattamente su queste
questioni, evidenziando la resistenza al vulnerabile nel maschile
performativo. A me interessa qui invece la questione politica, ovvero mi
interessano le conseguenze politiche dell'interdizione delle funzioni
desideranti nel maschile. Perchè “del maschile”: perchè storicamente il
maschile è stato luogo di privilegio, e come nel caso di Jung, dal
privilegio è disceso spesso, per viltà ed opportunismo, il ripiegamento
del desiderio nell'esistente ed il ricorso quasi sistemico al femminile
come intermezzo. Con tutte le contraddizioni del caso, il desiderio
inteso come forza rivoluzionaria assume nel femminile un potenziale
dirompente antiteticamente meno negoziabile del desiderio maschile, ed
una carica erotica la cui riappropriazione fuori ed oltre l'intermezzo è
ciò che di più potente esiste al mondo. Su questo voglio tornare, ma
per ora desidero ragionare sul modo in cui il ripiegamento del desiderio
nell'esistente ha aperto alla vendetta sulla differenza: il desiderio
imbestialito dei militari in guerra, il desiderio degli orchi di Arcore
per meraviglie adolescenti opportunisticamente conformate al patologico,
l'italiano su due che trivella a pagamento vita dalle donne, quelle
stesse donne che puntano dall'intermezzo al potere maschile: che cos'è
tutto questo se non un desiderio perfettamente inserito nel
capital/Edipo che estrae gasolio per competizione dalle relazioni con
l'altr@?
La parte delicata è che tale ripiegamento sfocia inevitabilmente non
solo nella ricerca del potere, ma anche della sottomissione. Le due cose
del resto sono inscindibili: il piedistallo di Jung che cos'è se non
l'incapacità di rapportarsi orizzontalmente a Sabina? Ma questo punto è
controverso in quanto dall'osservatorio del corpo femminile, sui
piedistalli vive solamente il potere. Ecco che la questione diventa
delicata, perchè non solo ovunque c'è un piedistallo non vi è nulla di
orizzontale, ma perchè dal piedistallo discendono pratiche oppressive
che trascendono le identità politiche e da destra come da sinistra
introducono egualmente nelle relazioni affettive germi di terrore.

Ne parla in modo suggestivo Theweleit, il cui studio è interessante qui
non tanto per i risultati quanto appunto per le suggestioni. Theweleit
riflette sull'interdizione delle funzioni desideranti nel fascista. Il
fascista non è completamente nato, scrive Theweleit. Le sue funzioni
desideranti sono interdette nell'armatura dell'io esternalizzato che
quello costruisce. Con disciplina il fascista esclude rigorosamente dal
proprio mondo esterno tutto ciò che da dentro minaccia dissoluzione.
Ecco che la psiche fascista concepisce il mondo attraverso una serie di
opposizioni dialettiche nelle quali nega di volta in volta il femminile,
l'altro, il nomade, il migrante, il morbido, il tenero, il brulicante,
ovvero tutto ciò che minaccia hegelianamente di volta in volta la
possibilità di dissoluzione di sé, negando continuamente il diverso
dentro e fuori sino a ripiegare ferocemente nella moltiplicazione
dell'uno. Con mille semplificazioni, il rifiuto dell'altro si esprime
qui con la costruzione di meccanismi di aggressività perfettamente
inseriti nel quadro competitivo del capital/Edipo, in una infinita
ripetizione dell'uno che infondo non disegna altro che schematicamente
la meccanica stessa della storia del capitalismo. L'uomo bianco ha
lavorato per secoli alla moltiplicazione infinita dei pani e dei pesci
sino alla saturazione dei mari e dei pesci. Ha corso contro ai
competitori e alla minaccia di castrazione dei minareti (cito
Borghezio). Ha risolto la propria saturazione con la moltiplicazione
compulsiva della saturazione stessa, moltiplicando problemi e debiti
sino a che la crescita si è fatta declino e a pioggia ha restituito
declino al mondo. È patetica la prevedibilità moltiplicatrice e
compulsiva dei dittatori, come patetico è il loro terrore, l'apparato
repressivo e competitivo di cui solo sono capaci. Il problema vero però è
che se la riproduzione dell'uno nasce dalla paura dell'altro, allora
nelle relazioni attuali tra maschile e femminile prolifera il fascismo.
Partiamo dall'ovvio:“faccio una vita terribile, ho orari disumani. Sono
una persona giocosa, se ogni tanto sento il bisogno di una serata
distensiva come terapia mentale [...] nessuno alla mia età mi farà
cambiare stile di vita del quale vado orgoglioso''. Così dichiarava
Berlusconi sul caso Ruby. Similmente Tony Blair definiva le amanti come
uno strumento per uscire dalla"prigione del self control”, e noi donne
ben sappiamo come storicamente la consolazione del maschile
all'inettitudine che inevitabilmente nasce dalla competizione nel
capital/Edipo sia passata sui nostri corpi. Passi ora la minuzia dei
dittatorelli che giocano a fare la guerra e poi supplicano a pagamento
le donne di consolazione: il problema serissimo è che l'utilizzo della
donna come stampella si estende a tutte le fasce sociali, incluse quelle
oppresse o quelle colte.
Fa male ammetterlo, ma la ricerca di empowerment non a caso così detto
sul corpo dell'altro tradisce spesso un reinvestimento del desiderio
nella competizione con/tro i potenti, ove l'ambiguità del trattino
introduce nel desiderio un doppio legame con il piedistallo dei potenti
da una parte ed il femminile dall'altra. Doppio legame del desiderio
significa da un lato deriva autoritaria nei rapporti del maschile con il
femminile, e dall'altro competizione con/tro il potere per il potere,
in una relazione antinomica che minaccia di trasformare l'impeto
rivoluzionario in una forza autoritaria. In questo senso, scriveva
Foucault, “un investimento inconscio di tipo fascista, o reazionario,
può coesistere con l'investimento conscio reazionario” (Foucault, 116),
il che significa peraltro che si possano “perfettamente concepire delle
rivoluzioni che lascino per l'essenziale intatte le relazioni di potere
che avevano permesso allo stato di funzionare” (Foucault, 17). Ecco che
la discriminante tra potenti e rivoluzionari, generalmente assai più
ambigua nei prodromi che nelle conseguenze, si rende spesso facilmente
manifesta sul corpo delle donne.
Qui servono una specificazione e una parentesi. Si fa infatti un gran
parlare in questi giorni della supposta contrapposizione tra la
mercificazione dei corpi a destra e la libertà dell'amore a sinistra. Ma
tolto il fatto che in questo mondo non ci sono libertà né amore, e
dunque l'argomento è miope o quantomeno ingenuo, il punto è che la
sessualità è intrisa di potere. Ecco che la contrapposizione tra
mercificazione o libertà, tra innocente femminile e maschile
autoritario, tra libertario e moralista o tra rivoluzionario e potente
viene sempre a cadere, in quanto tutte queste identificazioni rimangono
inserite nel cortocircuito del capital/Edipo. Il bandolo oltre al
cortocircuito in questo senso non può coincidere nè con l'identità nè
con la morale. Il bandolo risiede solo nella necessità di spostare il
discorso dalle categorie di identità politica o di morale alla categoria
unica di desiderio. Il problema infatti non è dove avviene il
ripiegamento del desiderio nel capitale/Edipo. Il problema è che
avviene. Il problema non è che una figlia di migranti tenti la scalata
al potere trasformando una stampella tappezzata di diamanti nel punto
più alto (o più basso) dell'immaginario femminile. È che il ripiegamento
del desiderio entro l'esistente contraddice sempre la produzione di
nuove corrispondenze tra sessualità e desiderio, tra desiderio e vita, e
ripiega così il desiderio in una forza oppressa tanto a destra quanto a
sinistra, tanto tra le donne quanto tra gli uomini, tanto tra i potenti
quanto tra i compagni. Ma se i potenti come vampiri vivono della
riproduzione dell'esistente, per tutti noi questo diventa invece una
problematica contraddizione.
Tornano qui puntuali le famose parole di Wilhelm Reich: perchè
sopportiamo da secoli lo sfruttamento, l’umiliazione, la schiavitù, fino
al punto di volerli non solo per gli altri, ma anche per noi stessi?
[…] Perchè coloro che soffrono la fame non rubano sempre e coloro che
vengono sfruttati non si ribellano? “Le masse non sono state ingannate,
esse hanno desiderato il fascismo in un determinato momento, in
determinate circostanze, ed è questo che bisogna spiegare, la
perversione del desiderio gregario” rispondono Deleuze e Guattari
(Deleuze e Guattari, 32). Il ripiegamento sul piedistallo o
sull'intermezzo come compensazione per l'assenza di libertà, qualunque
sia l'identità politica o di genere che lo produce, reinserisce il
desiderio nel capital/Edipo e lo costringe all'interno degli stessi
confini di cui brama il varco. È questa la perversione del desiderio di
cui parla Guattari. E la causa di questa perversione non ha nulla a che
fare con la morale. È perversa solo in quanto controrivoluzionaria.
Come si libera la fantasia del desiderio dopo decenni di ripiegamento
nel capitale/Edipo vestito nei due sessi? È questa la domanda. E lo
scarto sta esattamente nella scelta tra l'abbandono di sè alla
potenzialità distruttiva del desiderio immanente, e l'abbandono del
desiderio per il salvataggio dell'esistente. È lì che la differenza
diviene nemica o complice. La relazione con la differenza è l'angolo nel
cui rovesciamento l'interdizione delle funzioni desideranti verso il
femminile, l'altro, il migrante, il morbido, il tenero, il brulicante,
si scioglie in caosmosi proliferante. Il rovesciamento di quest'angolo
trasforma la verticalità dell'uno in molteplicità orizzontale e
promiscua. Ecco che il segreto sta nella potenza che si libera
dall'incontro con l'altro inteso tanto come intersessuale e
controsessuale. È in questo incontro che il desiderio si fa costituente,
nella trasformazione in potenza della nudità vulnerabile condivisa. A
favore di Jung dobbiamo dunque dire che affatto semplice è l'abbandono
alla vulnerabilià che il desiderio rende manifesta: “Questi uomini del
desiderio (oppure non esistono ancora) sono come Zaratustra. Conoscono
incredibili sofferenze, vertigini e malattie. Hanno i loro spettri.
Devono reinventare ogni gesto. Ma un tal uomo si esibisce come uomo
libero, irresponasbile, solitario e gioioso, capace infine di dire e di
fare qualcosa di semplice in nome proprio, senza chiedere il permesso,
desiderio che non manca di nulla, flusso che supera gli sbarramenti e i
codici, nome che non designa più alcun io” (Deleuze e Guattari,
146-147).
È oltre l'io che il desiderio diviene rivoluzionario. È nel passaggio
oltre il singolare, nella compenetrazione del maschile nel femminile e
del femminile nel maschile ed in questa miscela molteplice che si
schiude la potenzialità costituente del desiderio. Il desiderio teme il
superamento della crisi di sperdimento che si manifesta al limite dei
propri confini, e nel contempo brama la penetrazione catartica
nell'intermittenza orgasmica dell'ignoto. Così, risalendo lentamente
l'ignoto dell'altro interno, si schiude la sorgente della forza dolce
che si annida nella carezza del cuneo più doloroso dell'essere umano.
Quella sorgente sola può aprire alla potenza sublime del desiderio
immanente. La meraviglia orgasmica del desiderio immanente sta
esattamente qui, nella disponibilità all'abbandono dolce alla
distruzione dell'ordine che restituisce fecondità alla terra penetrando
delicatamente gli inferi di una crisi nel cui buio solamente il profumo
del desiderio diviene direzione. L'abbandono all'incontro con la nudità è
la speranza nella quale vive il futuro: è lì, nel fare l'amore con il
desiderio d'altro e dell'altro che si rimescolano di curve i
verticalismi intermezzati e dialettici del vecchio potere maschile e che
la molteplicità del desiderio tenero e vulnerabile delle moltitudini
diventa una forza costituente.
Non dunque nel maschile singolare o nel femminile singolare trova
soluzione il terrore che vive nelle relazioni affettive. Bensì “oltre
l’io il soggetto esplode in tutto l’universo storico, il delirante
incomincia a parlare lingue straniere, soffre di allucinazioni che
modificano la storia; i conflitti di classe o le guerre diventano gli
strumenti dell’espressione di sé” (Deleuze e Guattari, 147). Solo oltre
l'io rinascono intrecciate le relazioni e la storia d'amore tra Sabina e
Jung trova libertà. Oltre l'io la bomba di terrore misto a fecondità
esplode in un fuoco d'artificio di miele. Nulla più ha importanza
allora. La rivoluzione diventa un orgasmo d'amore in cui fiorisce
proliferante la fantasia molteplice.
Bibliografia
A. Carotenuto, Diario di una Segreta Simmetria, Astrolabio, Roma, 1980.
G. Deleuze e F. Guattari, L'Anti-Edipo, Einaudi, Torino, 1975.
M. Foucault, Microfisica del Potere, Potere-Corpo. Einaudi, Torino, 1972.
F. Hegel, Scienza della Logica Libro III, Laterza, Bari, 1968.
L. Irigaray, Speculum, Feltrinelli, Milano, 1975.
W. Reich, Psicologia di Massa del Fascismo, Mondatori, Milano 1977.
S. Spielrein, La distruzione come causa della nascita, in: Giornale Storico di Psicologia Dinamica, vol. 1, n. 1, 1977.
By